Tra tutti i sacramenti della Chiesa, la
riconciliazione o confessione è forse quello che ha subito più trasformazioni
lungo i secoli. E questo non è senza motivo. Da una parte vi è la fede della
chiesa che crede e insegna di aver avuto il potere di perdonare i peccati,
dall’altra il peccatore concreto con la sua storia, quindi non semplicemente
una dottrina da applicare, ma una persona da accogliere, una prassi da
inventare.
Nel Nuovo Testamento la prima, vera e più importante, e per alcuni l’unica, remissione dei peccati è il Battesimo: «pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati» (Atti 2,38) dice l’apostolo Pietro nel suo discorso la mattina di pentecoste. Nella professione di fede che recitiamo nella messa domenicale, diciamo di credere «in un solo battesimo per la remissione dei peccati». È nel Battesimo, dunque, che muore l’uomo vecchio con i suoi peccati e le sue concupiscenze e nasce l’uomo nuovo creato secondo Dio.
Il Battesimo, però, non va inteso in senso quasi magico che assicuri la salvezza senza un concreto impegno del credente reso possibile dal Battesimo.
Nel Nuovo Testamento la prima, vera e più importante, e per alcuni l’unica, remissione dei peccati è il Battesimo: «pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati» (Atti 2,38) dice l’apostolo Pietro nel suo discorso la mattina di pentecoste. Nella professione di fede che recitiamo nella messa domenicale, diciamo di credere «in un solo battesimo per la remissione dei peccati». È nel Battesimo, dunque, che muore l’uomo vecchio con i suoi peccati e le sue concupiscenze e nasce l’uomo nuovo creato secondo Dio.
Il Battesimo, però, non va inteso in senso quasi magico che assicuri la salvezza senza un concreto impegno del credente reso possibile dal Battesimo.
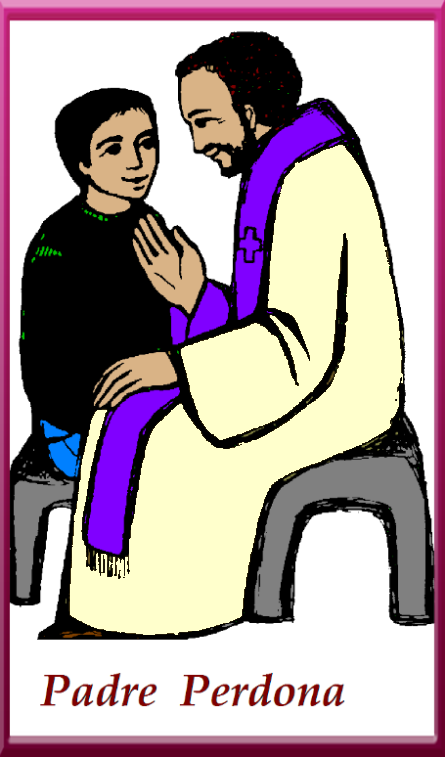
 All’udienza generale del 26 febbraio, proseguendo nel ciclo di catechesi sui sacramenti, Papa Francesco ha proposto una meditazione sull’Unzione degli infermi, chiamata anche – specie in passato – «Estrema unzione». Il nome che si preferisce oggi, Unzione degli infermi, ha detto il Papa, «ci aiuta ad allargare lo sguardo all’esperienza della malattia e della sofferenza, nell’orizzonte della misericordia di Dio».
All’udienza generale del 26 febbraio, proseguendo nel ciclo di catechesi sui sacramenti, Papa Francesco ha proposto una meditazione sull’Unzione degli infermi, chiamata anche – specie in passato – «Estrema unzione». Il nome che si preferisce oggi, Unzione degli infermi, ha detto il Papa, «ci aiuta ad allargare lo sguardo all’esperienza della malattia e della sofferenza, nell’orizzonte della misericordia di Dio».



 Il 15 febbraio corrono 450 anni dalla nascita di Galileo Galilei (Pisa, 1564 – Arcetri (FI), 1642). Galileo è stato uno dei più importanti iniziatori del metodo scientifico, cioè di quel modo di fare scienza che, unendo teoria e verifica sperimentale, costituisce “la scienza” quale oggi è conosciuta e praticata in tutto il mondo. Tuttavia, il suo nome, è soprattutto legato alla vicenda che lo vide contrapposto alla Chiesa cattolica e il “caso Galileo” è diventato — come “il Medioevo”, “le Crociate”, “l’Inquisizione” – il simbolo della lotta fra una Chiesa “oscurantista” e “retrograda” e una scienza “luminosa” e “moderna”. Qui di seguito viene proposto un breve vademecum, una piccola guida da tenere sempre a portata di mente ogni volta che siamo chiamati a riflettere e a rispondere sulla vicenda che da troppi secoli avvelena i rapporti tra scienza e fede.
Il 15 febbraio corrono 450 anni dalla nascita di Galileo Galilei (Pisa, 1564 – Arcetri (FI), 1642). Galileo è stato uno dei più importanti iniziatori del metodo scientifico, cioè di quel modo di fare scienza che, unendo teoria e verifica sperimentale, costituisce “la scienza” quale oggi è conosciuta e praticata in tutto il mondo. Tuttavia, il suo nome, è soprattutto legato alla vicenda che lo vide contrapposto alla Chiesa cattolica e il “caso Galileo” è diventato — come “il Medioevo”, “le Crociate”, “l’Inquisizione” – il simbolo della lotta fra una Chiesa “oscurantista” e “retrograda” e una scienza “luminosa” e “moderna”. Qui di seguito viene proposto un breve vademecum, una piccola guida da tenere sempre a portata di mente ogni volta che siamo chiamati a riflettere e a rispondere sulla vicenda che da troppi secoli avvelena i rapporti tra scienza e fede.



